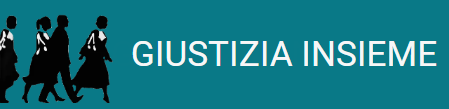Diario dal Consiglio del 24 maggio 2025
Un decreto dove dilaga la punizione del dissenso
Lo scorso 14 maggio il CSM ha approvato – con quattro voti contrari (i laici Aimi, Bertolini, Bianchini ed Eccher) e un’astensione (il laico Giuffrè) – la delibera proposta dalla Sesta commissione di adozione di un parere ex art. 10, co. 2, della legge n. 195 del 1958, sul c.d. “decreto sicurezza” (d.l. 11.4.2025 n. 48).
Il decreto-legge è composto da trentanove articoli e riproduce quasi alla lettera il contenuto di un disegno di legge di iniziativa governativa già all’esame delle aule parlamentari. Con tale provvedimento – che trasferisce in sede di decretazione di urgenza contenuti normativi su cui già era iniziato un vivace dibattito parlamentare, ovviamente destinato ad essere compresso dal necessario rispetto dei tempi per la conversione in legge – il Governo tenta di affrontare un ampio e diversificato ventaglio di fenomeni di devianza ricorrendo in maniera accentuata allo strumento penale, declinato nelle due forme dell’inasprimento delle pene (mediante l’innalzamento dei limiti edittali o l’introduzione di nuove aggravanti) e dell’introduzione di nuove fattispecie di reato.
Il parere approvato del Plenum non prende posizione sulla questione – evocata, ma ritenuta estranea al perimetro definito dall’articolo 10 legge n. 195/1958 – del passaggio dallo strumento del disegno di legge a quello del decreto-legge, ma si confronta, piuttosto, con le ricadute sistematiche e applicative delle nuove disposizioni, non mancando di sottolineare come, in linea di principio, il panpenalismo non favorisca l’efficienza degli uffici giudiziari, ma contribuisca, piuttosto, a ingolfarne i ruoli.
Rimandiamo alla lettura del parere, molto ampio e circostanziato, per l’esame analitico dei rilievi mossi in relazione alle numerose disposizioni che istituiscono nuove figure di reato o inaspriscono il trattamento sanzionatorio di figure di reato esistenti.
Qui ci limitiamo a sottolineare come molte disposizioni del decreto sicurezza risultino improntate alla stigmatizzazione della manifestazione del dissenso: la violenza o minaccia a pubblico ufficiale diviene aggravata se finalizzata a impedire la realizzazione di infrastrutture dei servizi pubblici (art. 339 c.p.); il danneggiamento è aggravato se commesso in danno di edifici pubblici “al fine di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione” (art. 639, co. 2 c.p.); viene reintrodotto il reato di c.d. blocco stradale con il proprio corpo di strade non ferrate, già depenalizzato nel ‘99 (d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e che spesso si traduce in atti di mera resistenza passiva; è inasprita la pena per il danneggiamento in occasione di manifestazioni, aggravato da violenza o minaccia (art. 635 c.p.).
Sulla stessa scia si pone la criminalizzazione delle rivolte in istituti penitenziari e in centri per l’immigrazione, disposta dagli articoli 26 e 27.
Il nuovo art. 415-bis c.p. punisce gli atti di resistenza in istituti penitenziari a ordini impartiti “per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza”, incluse “le condotte di resistenza passiva”. Il profilo di più immediata criticità è rappresentato dalla criminalizzazione della resistenza passiva, un unicum nel nostro diritto penale, in aperta tensione con il principio di materialità. A questo riguardo si segnala anche l’assenza di parametri chiari a cui ancorare la quantificazione della pena, che va determinata avendo riguardo al numero di persone coinvolte, mentre per il caso della violenza o minaccia la legge indica la soglia delle tre persone (ponendo anche problemi di coordinamento delle due disposizioni).
L’art. 27 introduce una disposizione analoga all’art. 415-bis c.p. per il caso della rivolta e resistenza passiva presso centri per l’immigrazione (nuovo comma 7.1. dell’art. 14 T.U. immigrazione), che non solo si espone ai medesimi rilievi dell’art. 415-bis c.p., ma che, per di più, equipara impropriamente le persone collocate presso centri per l’immigrazione a quelle ristrette in quanto destinatarie di condanne o misure cautelari.
Rilevante è anche l’art. 10 del decreto-legge, che reca modifiche al c.p. e al c.p.p. per rendere più efficace il contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili. L’intervento normativo si muove su un doppio versante, introducendo il reato di occupazione di immobile “destinato a domicilio altrui”, se commesso mediante violenza o minaccia o con artifizi e raggiri (nuovo art. 634-bis c.p.) – punito con pene sensibilmente più alte rispetto alla fattispecie-base di occupazione arbitraria ex art. 633 c.p. – e prevedendo una specifica procedura d’urgenza per il rilascio di tali immobili (nuovo art. 321-bis c.p.p.), su richiesta del pubblico ministero o, nei casi più urgenti, per ordine della polizia giudiziaria.
Sul piano sistematico, la reintegrazione coatta ex art. 321-bis c.p.p. si sovrappone alla tutela civilistica possessoria (articoli 703 ss. c.p.c.), con una prevedibile attrazione della stragrande maggioranza dei casi in sede penale. Come sottolineato da Antonello in Plenum, “il livello di entropia del sistema cresce ancora”, con soluzioni sempre più confuse e meno limpide nei loro principi regolativi.
Merita attenzione anche la modifica della regola del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza o con prole fino a un anno, che diviene facoltativo e comunque non più possibile in caso di rischio di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti. Laddove si disponga l’esecuzione immediata, il collocamento deve necessariamente avvenire presso un istituto a custodia attenuata (ICAM), che rappresenta invece una mera possibilità per le detenute madri con prole di età compresa tra uno e tre anni. Il differimento obbligatorio era già previsto dal Codice Rocco (art. 146, co. 1, c.p.) e aveva superato il vaglio di costituzionalità in ragione della natura umanitaria e assistenziale delle esigenze che la sorreggevano.
Oltre alla evidente frizione con i diritti fondamentali dei bambini, la disposizione rischia anche di pregiudicare il rispetto del principio di territorialità della pena, a causa di un dato strutturale: essendo gli ICAM in numero di quattro, di cui peraltro solo uno nell’Italia centro-meridionale (Avellino), la maggior parte delle detenute incinte o neomamme sarà costretta ad allontanarsi dal proprio centro di relazioni familiari e sociali. Il rischio è quello dell’indebolimento delle relazioni affettive – indotto dalla distanza tra l’istituto e il contesto familiare di riferimento – che conduce alla “desertificazione affettiva” che, nelle parole della Consulta, “è l’esatto opposto della risocializzazione” cui la pena deve tendere secondo la bussola costituzionale (C. cost. n. 10/2024, par. 4.3).
In definitiva, il parere del CSM auspica una rimeditazione da parte del legislatore, in sede di conversione, al fine di chiarire la portata del testo normativo e assicurare la tenuta sistematica dell’ordinamento. Difficile, peraltro, non notare lo stridente contrasto tra l’impostazione pan-penalistica esibita in questo intervento normativo e la recente depenalizzazione del più paradigmatico tra i reati dei colletti bianchi, l’abuso di ufficio (legge 9.8.2024 n. 114).
Nel ricco dibattito in Plenum, i membri togati del Consiglio e il laico Papa hanno lanciato un corale grido d’allarme. In particolare, la prima Presidente Cassano ha evidenziato, tra l’altro, le ricadute dirompenti del decreto sicurezza sull’efficienza del sistema giudiziario, pregiudizievoli anche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.
Marcello ha evidenziato come l’ipertrofia penalistica che connota le nuove disposizioni rischi di far slittare verso il basso la priorità per le procure di fattispecie che richiedono interventi tempestivi, come la violenza di genere (oggetto di recente monitoraggio da parte del Consiglio).
I laici Giuffrè e Bertolini hanno invece contestato il parere consiliare, lamentando uno sconfinamento dal perimetro delle funzioni dell’organo di autogoverno. A loro avviso, il parere si esprime inopportunamente sulle scelte di politica criminale, prerogativa del legislatore. Per noi queste censure sono infondate: il CSM può e deve segnalare le ripercussioni delle innovazioni legislative sul lavoro quotidiano e degli uffici giudiziari e deve far sentire la propria voce, così come, del resto, sul decreto sicurezza l’hanno fatta sentire, con inusuale sintonia, l’ANM, l’Unione delle Camere Penali e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello