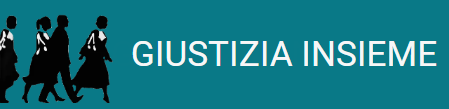Area democratica per la giustizia è un’associazione di magistrati che sono convinti che la giurisdizione, come gli altri poteri dello Stato, debbano attuare non solo le norme ma anche i valori espressi nella nostra Costituzione. Il sistema del governo autonomo della magistratura, tutelando la autonomia e l’indipendenza dei magistrati, serve proprio a garantire la funzione che la Carta assegna alla giurisdizione. La magistratura ed il suo governo autonomo vivono un periodo difficile, schiacciati fra il revanscismo della politica e la difficoltà di fare giustizia nell’epoca dei “poteri selvaggi” che sfuggono alla sovranità nazionale e rispondono solo all’interesse di chi li esercita. Conosciamo i limiti ed i difetti del potere giudiziario e di chi lo amministra ma siamo certi che, se non ne fosse garantita l’autonomia ed l’indipendenza, le prime vittime sarebbero i cittadini più indifesi. Per ragionare su questi temi, ed anche altro, ospitiamo sul sito di Area DG una nuova rubrica, che sarà poi meglio strutturata nelle prossime settimane.
Giovanni Ciccio Zaccaro
La professionalità dei magistrati è il fondamento della loro legittimazione democratica e dunque è centrale il tema dell’accesso alle funzioni e della formazione dei magistrati. Le enormi scoperture di organico legittimano modalità di accesso meno severe? Si può immaginare un percorso formativo fin dalle aule universitarie? Di questo ed altro si parlerà nel convegno organizzato da AreaDG a Milano.
Il mestiere della toga
La carenza di magistrati ha raggiunto soglie preoccupanti (mancano più di mille magistrati), gli obiettivi del PNRR incombono: il tema dell’accesso alla magistratura e della formazione gioca un ruolo fondamentale.
Una riflessione non può più essere rinviata perché sotto questa scure della (necessaria) aspirazione all’efficienza, in un contesto di cronica emergenza, il rischio di perdere per strada la qualità è alto. È la garanzia di una tutela efficace dei diritti la vera essenza di un servizio elevato.
Per queste ragioni, riflettere su possibili riforme del concorso in magistratura e sui percorsi di avvicinamento ad esso necessita in primo luogo di chiarirci su quali siano le qualità di un magistrato in una società moderna, plurale e complessa come la nostra.
Il tema dell’istruzione ci insegna che il cambiamento è l’unica costante.
Ad oggi noi non siamo in grado di prevedere nel 2050 come sarà il mondo, quale sarà la cultura ed il costume che informerà le relazioni umane. Questo accadeva anche prima ma le persone confidavano che alcune caratteristiche della società sarebbero rimaste immutate. Oggi non è più così.
Quasi tutti i sistemi scolastici e universitari impostano i loro programmi didattici sull’accumulo di nozioni. Questa impostazione, ancora oggi valida, nasceva dalla dominabilità delle informazioni a disposizione. Oggi, invece, siamo travolti da una smisurata quantità di informazioni, non tutte veritiere o verosimili; basta un clic o una conversazione con forme di intelligenza artificiale per accedere a resoconti dettagliati dei più singolari accadimenti storici o ad un testo di una cultura lontana.
Proprio per questa ragione oggi gli esperti di pedagogia richiedono di ripensare il modello di accumulo di nozioni specialistiche e inseguire, invece, la necessità di fornire strumenti critici per interpretare le informazioni a nostra disposizione, per distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è e per poter inquadrare le tematiche in un orizzonte di senso più ampio.
In questa prospettiva, si propone di impostare la didattica sulle note “quattro C”: critica, comunicazione, collaborazione e creatività. La ricerca è quella di sviluppare le capacità in grado di gestire il cambiamento e di mantenere il controllo in situazioni di emergenza. Per sopravvivere in un mondo in costante cambiamento c’è bisogno di grande flessibilità mentale e di equilibrio emotivo.
In questo scenario generale, preoccupante ma allo stesso tempo stimolante, anche il percorso di studi per l’accesso alla magistratura deve essere oggetto di attenzione.
La legge 71/2022 ha ristabilito l’accesso diretto al concorso in magistratura, come invocato per tanto tempo, e ridotto le materie oggetto di prova orale.
Eppure, anche in seguito a percorsi di specializzazione, spesso affidati a scuole private, la percentuali di candidati che superano le prove scritte è incredibilmente bassa (circa il 5%): che il concorso mantenga una tale severità è certamente giusto, trattandosi di una ineludibile garanzia per la giurisdizione.
Forse, tuttavia, la capacità di scrittura degli aspiranti candidati deve essere implementata fin dall’università. Questo non significa, certo, abbandonare i metodi didattici tradizionali, che caratterizzano l’accademia italiana come una delle più importanti in Europa, ma abbinare strumenti che siano in grado di sviluppare capacità prima sottostimate.
Il giurista moderno deve dominare un numero di fonti, in costante interazione tra loro, prima inesistente; deve confrontarsi con saperi nuovi e specialistici, non ancora normati; deve saper argomentare decisioni e orientarsi nell’incertezza, riconoscendo diritti prima ignoti.
La capacità di scrivere, anche come espressione della capacità di comunicare, deve essere certamente implementata nel percorso universitario, senza sacrificare per questo lo sviluppo degli strumenti critici di interpretazione della realtà.
Sempre la legge 71/2022 ha stabilito che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari.
Premessa ogni valutazione critica sulla scelta dei partecipanti, sui costi e sui presupposti di accesso, questa novità ci interroga anche su come organizzare questi futuri corsi, provando a immaginare un corpo docente stabile, percorsi di collaborazione con le università. Tuttavia, che la magistratura ordinaria svolga un ruolo nel percorso di avvicinamento al concorso è una novità da accogliere con favore, in un mondo finora dominato dalle scuole private, proprio perché in grado di saper trasferire allo studente l’esperienza del costante mutamento della realtà e la successiva necessità di dominare tecniche di interpretazione e argomentazione (quest’ultima spesso sottovalutata).
In questo senso, allora, la ricerca di strumenti critici di interpretazione della realtà rappresenta anche un argine a studi meramente casistici, tutti rivolti ad uno studio meramente ricognitivo degli orientamenti giurisprudenziali.
Allo stesso modo, i tirocini formativi (oggi non più obbligatori e quindi meno appetibili) e l’ufficio del processo (soprattutto in un’auspicata ottica di stabilizzazione) devono essere ricalibrati, nella ricerca di un delicato equilibrio tra formazione e professionalità.
Infine, la formazione iniziale. È giunta l’ora di una riflessione globale, di meditare sui contenuti e metodi della stessa, sulla ricerca di un coordinamento tra Scuola Superiore e organizzazione dei tirocini; sulla implementazione di stage di lunga durata; della ricerca di equilibrio tra metodo casistico e tecniche di interpretazione; sullo studio di nuove materie, a partire dalle interazioni con l’intelligenza artificiale; sui sistemi di valutazione della formazione stessa.
Formazione iniziale ma anche comune. La cultura della giurisdizione appartiene a tutti gli attori della stessa. Oggi, dopo il percorso di laurea, i sentieri della specializzazione delle diverse professioni si allontanano tra loro. L’esigenza, invece, di un linguaggio comune impone di ripensare percorsi comuni a tutti i diversi attori, evitando gli errori del passato (ad esempio il mero sdoppiamento del percorso di laurea).
La posta in gioco è alta e per questo vale la pena provare ad impostare una riflessione che, partendo dalla individuazione delle qualità di un magistrato nel tempo del cambiamento, sappia, di conseguenza, immaginare percorsi nuovi che sappiano coniugare comprensione, interpretazione ed argomentazione.
Di questo e di tanto altro parleremo a Milano, venerdì 3 marzo dalle ore 15.00, partendo proprio dall’esperienza di giovani magistrati e tirocinanti, che ci racconteranno la loro storia.
Vincenzo Giordano
Tribunale di Pavia
26 febbraio 2023
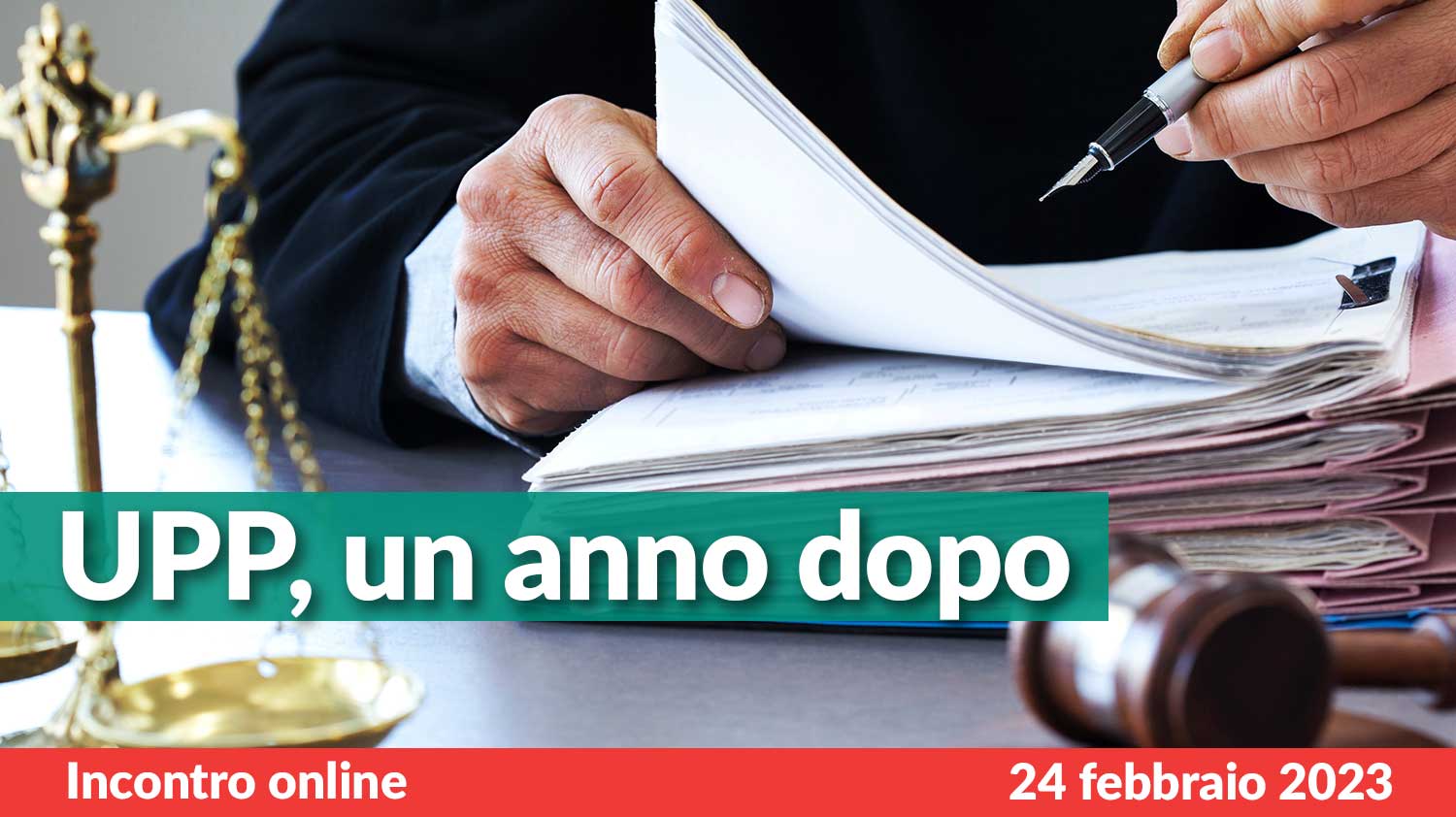
Area democratica per la giustizia è un’associazione di magistrati che sono convinti che la giurisdizione, come gli altri poteri dello Stato, debbano attuare non solo le norme ma anche i valori espressi nella nostra Costituzione. Il sistema del governo autonomo della magistratura, tutelando la autonomia e l’indipendenza dei magistrati, serve proprio a garantire la funzione che la Carta assegna alla giurisdizione. La magistratura ed il suo governo autonomo vivono un periodo difficile, schiacciati fra il revanscismo della politica e la difficoltà di fare giustizia nell’epoca dei “poteri selvaggi” che sfuggono alla sovranità nazionale e rispondono solo all’interesse di chi li esercita. Conosciamo i limiti ed i difetti del potere giudiziario e di chi lo amministra ma siamo certi che, se non ne fosse garantita l’autonomia ed l’indipendenza, le prime vittime sarebbero i cittadini più indifesi. Per ragionare su questi temi, ed anche altro, ospitiamo sul sito di Area DG una nuova rubrica, che sarà poi meglio strutturata nelle prossime settimane.
Giovanni Ciccio Zaccaro