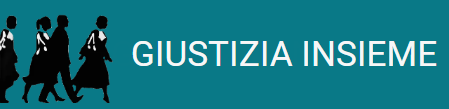Cronaca di una tragedia annunciata
Micaela aveva 12 anni. Quel giorno era andata a scuola, aveva seguito le lezioni, scherzato con le amiche, come sempre. Poi era tornata a casa, pranzato con mamma, nonna e suoi fratelli. Aveva fatto i compiti, aspettando la cena per rivedere papà, di ritorno dal cantiere.
Ma non era serena. Non poteva esserlo. C’era una strana aria, in quei primi giorni di ottobre, racconta. In paese si sentivano strani discorsi.
“La gente bisbigliava continuamente, ma non capivamo bene di cosa, almeno noi bambini”. Il tempo era come sospeso. La gente aveva paura. C’erano continui boati, scosse di terremoto. Ma veniva rassicurata. Non c’è pericolo, dicevano. Bisogna ultimare il collaudo.
Quindi la tragedia. Alle 22:39 del 9 ottobre 1963, 270 milioni di m³ di roccia si staccavano dal monte Toc, precipitando sulle acque del bacino artificiale realizzato dalla diga del Vajont – all’epoca la più grande al mondo – causando un’onda di 250 metri, che tracimando dal colmo della diga distrusse tutto ciò che incontrò a valle.
Dapprima lo spostamento d’aria causò una specie di uragano, raccontano i testimoni. Poi, in pochi minuti, 25 milioni di metri cubi di acqua e detriti raggiunsero Longarone, insieme alle frazioni limitrofe, spazzando via la quasi totalità degli abitanti. Vennero distrutte 895 abitazioni, e 205 unità produttive. I morti furono 1917, di cui 487 tra bambini e adolescenti, 400 dei quali mai più ritrovati.
“Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita, gli uomini non ci hanno messo le mani: tutto è stato fatto dalla natura che non è buona e non è cattiva, ma indifferente.” Così scriveva Giorgio Bocca su “Il Giorno” l’11 ottobre 1963.
In buona fede, sicuramente. Anche perché la diga, riuscendo a sopportare forze 20 volte superiori a quelle per cui era stata progettata, rimase miracolosamente intatta. Come lo è ancora oggi.
Eppure, c’era qualcuno che aveva provato a lanciare l’allarme. Come la giornalista de L’Unità, Tina Merlin, che da anni denunciava l'esistenza di un sicuro pericolo. “Il terreno continua a cedere” scriveva, “si sente un impressionante rumore di terra e sassi che continuano a precipitare. E le larghe fenditure sul terreno che abbracciano una superficie di interi chilometri non possono rendere certo tranquilli”. Rimase inascoltata.
Anzi, fu addirittura denunciata per "diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico". Quindi processata e assolta dal Tribunale di Milano, solo per aver scritto dell’esistenza di studi geologici che attestavano il fatto che l'area era tutt'altro che stabile, come dimostrato dai numerosi precedenti di eventi franosi lungo la valle.
L’ultimo dei quali il 4 novembre 1960, quando 800.000 m³ di roccia si staccarono dal monte per cadere nel bacino artificiale, provocando un'ondata di 10 metri di altezza. Contemporaneamente si aprì una immensa fessura perimetrale sulla montagna disegnando la forma di una M, lunga oltre 2.500 m sulle pendici settentrionali della montagna.
Insomma, la natura una volta tanto si era mostrata benigna: aveva lanciato il suo avvertimento. Ma rimase inascoltata. Altre furono le voci cui i responsabili dell’opera decisero di dare ascolto.
La verità sulla frana del Vajont è scritta nelle sentenze delle Corte d’Appello di L’Aquila e della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la prevedibilità dell’evento, pronunciando condanna per omicidio colposo plurimo con l’aggravante della prevedibilità per l’ing. Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della S.A.D.E., e per l’ing. Francesco Sensidoni, ispettore generale del Genio Civile e componente della commissione di collaudo della diga. L’ing. Mario Pancini, direttore dell'ufficio lavori al cantiere del Vajont, si tolse la vita prima dell’inizio del processo.
In un articolo pubblicato su “La Repubblica” del 22 settembre 2013, Marco Paolini, che con il suo spettacolo teatrale ha avuto il merito di aver fatto conoscere agli italiani la storia “di una delle più grandi sciagure provocate dall’uomo”, nel titolo sottolineava “sono passati cinquant’anni ma non abbiamo imparato la lezione”.
Purtroppo, a distanza di sessantuno anni, ancora oggi, siamo chiamati ad interrogarci su quante catastrofi, quanti morti, quante leggi disattese, quanti eventi dimenticati, quanti omessi controlli dovranno susseguirsi prima di assistere ad un autentico risveglio delle coscienze.
Prima che la vita e la salute delle persone siano effettivamente poste al primo posto nella scala dei valori, come la nostra Costituzione ci insegna.
Anch’essa, troppo spesso, inascoltata.
Mentre oggi la Legge 101/2011 all’art.1 sancisce: “La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo”.
Gaetano Ivan Sole
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.