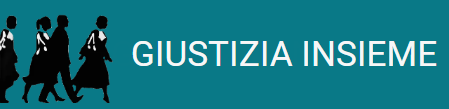Il buco nero del diritto
I primi prigionieri arrivano l’11 gennaio del 2002. Il C141 della forza aerea americana tocca terra e, per prima, scende della pancia dell’aereo un’enorme struttura metallica blu, con tazze e lavelli rudimentali: i bagni, privati delle porte per motivi di sicurezza. 25 minuti più tardi scendono, uno a uno, uomini vestiti con tute arancioni, scarpe di tela con suola in plastica, anch’esse arancioni, e calze blu. Sono bendati, hanno tappi nelle orecchie, una maschera che copre naso e bocca ed un pesante cappotto blu sopra la tuta, con mani e piedi ammanettati alla cintura.
Dopo la visita iniziale vengono sistemati ciascuno in celle di due metri per due, con tetto in compensato e pavimento di cemento; le pareti delle gabbie sono fatte da due file di filo di ferro in modo che le guardie, sia di giorno che di notte, vedano tutto ciò che avviene all’interno; perciò la sera si accendono sedici potenti fasci di luce che restano accesi tutta la notte. Se piove, i prigionieri si bagnano; la temperatura supera i 40 gradi già alla metà al mattino. Le guardie li scortano anche in bagno, e non possono scambiare alcuna parola con loro né rivelare dove si trovano.
Sono gli “high value detainee” secondo i servizi segreti e il Ministero della difesa USA: terroristi, persone altamente pericolose, “combattenti nemici illegali” catturati in Afghanistan e in Pakistan, torturati, costretti fisicamente a nutrirsi durante mesi di sciopero della fame, ristretti senza processo e senza fine pena, fuori dal diritto federale ed anche dal diritto internazionale.
Se si trovassero sul suolo americano, godrebbero dei diritti costituzionali statunitensi; le basi USA in Iraq ed in Afghanistan vengono già utilizzate per gli “interrogatori rafforzati”, per esempio con la privazione del sonno; per la detenzione occorre un altro luogo, diverso sia dalle basi in Europa, dove la stampa e l’opinione pubblica sarebbero eccessivamente attente, sia dalle basi del mondo arabo, cui appartengono quasi tutti i prigionieri.
La base navale di Guantanamo è un luogo isolato, a mezzo miglio dalla frontiera con Cuba, in zona arida e asciutta, dove è possibile imporre regole severissime anche ai giornalisti: è il posto giusto insomma.
Dopo quattro anni nel corso dei quali centinaia di prigionieri vengono rinchiusi a Guantanamo, finalmente il 29 giugno 2006 la Corte Suprema USA, su appello del detenuto Salim Ahmed Hamdan, stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di giustizia militare perpetrata nel campo di prigionia.
La base tuttavia non viene smantellata né allora né quando il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, nel 2009, ne ordina la chiusura: il Congresso si oppone ed i democratici si uniscono ai repubblicani per impedire che sia dato seguito all’ordine del presidente.
Donald Trump emette un ordine esecutivo che tenga aperta la base a tempo indeterminato; Joe Biden, nonostante le dichiarazioni rese in campagna elettorale ed in tempi anche precedenti, non può vincere le resistenze dei democratici e della stessa CIA. Se i 39 prigionieri ancora presenti a Guantanamo fossero sottoposti a regolare processo, emergerebbero gli abusi e le torture subiti nel passaggio attraverso le prigioni segrete, come anche denunciato da Amnesty International.
È così che questi uomini non sono e non saranno incriminati, né processati, né giudicati.
Restano e resteranno nel “buco nero” di Guantanamo Bay, fuori da qualunque codice, convenzione, diritto; nel buco nero dell’odio che genera altro odio, a riprova che sì, è terribile morire, ma senza la tutela della legge lo è anche sopravvivere.
Antonella Marrone
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.
(giornata internazionale contro il lavoro minorile)