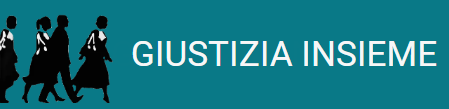Arrivare in via Tasso
Ci sono momenti in cui si vorrebbe veramente lasciar perdere. Momenti in cui la funzione esercitata, o il ruolo ricoperto, dentro e fuori la giurisdizione, infiltrano quel che ancora resta dell'iniziale entusiasmo, e travolgono le cose importanti della vita: la famiglia, le amicizie, gli amori, le passioni. Il lavoro del magistrato, sia esso svolto nei palazzi di giustizia o nelle istituzioni che sorreggono l'ordine giudiziario, è ugualmente ingrato: per complessità, per impegno, per le limitazioni che comporta. È soggetto a pressioni d’ogni tipo, e a volte sembra di essere sott'acqua, avvolti da una pressione di quattro atmosfere, almeno.
La magistratura è un servizio al Paese, di cui costituisce l'ossatura democratica: per questo non bisogna mai smettere di sentirsi onorati di contribuire alla prima delle funzioni vitali della Repubblica. Ma gli attacchi e le insinuazioni arrivano da ogni direzione, e ci si chiede spesso se ne valga la pena, o non sia meglio lasciar perdere: e dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione - finalmente - alla famiglia, le amicizie, gli amori, le passioni. Passando, cioè, dalla dimensione del servizio alla dimensione del lavoro. Fare lo stretto indispensabile, senza volersi occupare degli effetti sistemici delle proprie scelte, rimanere indifferenti al complessivo andamento del servizio-giustizia; lasciare ad altri la cura delle funzioni democratiche del Paese, per occuparsi - finalmente - del proprio orto. Essere burocrate. Timbrare il cartellino e andare a casa, se ce ne fosse uno da timbrare; per il momento non c’è, ma andando avanti così, dopo le pagelline e il resto, tutto è davvero possibile.
Era con questo stato d’animo che un giorno caldissimo di luglio mi sono trovato alla stazione Termini, e con largo anticipo rispetto all'orario di partenza del mio treno (le 13). Per poi scoprire, una volta lì, di avere mentalmente confuso gli orari: il mio treno sarebbe in realtà partito alle 15. Avevo due ore e mezza davanti, e nessun treno disponibile prima. Era stato quel mio masticamento amaro, a farmi anticipare freudianamente l'orario del treno che mi avrebbe ricondotto a casa. Poco male, ma era necessaria una scrollatura. Un refill avrebbe detto un compagno d’aperitivo.
Era necessario riprendere a seguire un filo dipanato dal giorno in cui ho superato gli orali del concorso in magistratura: quella notte dormii in un albergo di via Rasella, e poi, dopo gli orali, andai alle Fosse Ardeatine. Da quel periodo erano passati molti anni. Anche se nel frattempo avevo regalato alla mia tirocinante “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana”. Il miglior testo di preparazione al concorso in magistratura.
Era tempo che volevo visitare il Museo della Liberazione di via Tasso. Sapevo che non era troppo distante dalla stazione, ma non conoscendo la zona avevo solo una vaga idea delle reali distanze. Uscii nel solleone torrido della città e andai verso Vittorio Veneto trascinandomi dietro zaino e valigia. Attraversai il rumoroso isolato africano, e poi quello indifferente popolato da cinesi. Il sole era abbacinante, e mi fermavo spesso per detergermi. Ma perché stavo salendo fin lì? In realtà via Tasso era distante, e quasi irraggiungibile con zaino e valigia nell’afa cittadina dell’ora di punta. Ma ero spinto da una motivazione incrollabile: riprendere in mano il filo del dialogo con i martiri della Resistenza - il culto degli avi. Ecco cosa si poteva fare in quelle due ore.
Via Tasso è una strada anonima, lunga e stretta, a senso unico. Anche il palazzone giallo costruito negli anni Trenta è uguale a tutti gli altri, solo una lapide ricorda “il luogo dove più infierì la ferocia nazista e più rifulse l’eroismo dei martiri”. Ed è vero. Perché nell'immaginario collettivo via Tasso rappresenta le terribili torture delle SS sui partigiani condotte ininterrottamente dalla fine del 1943 al giugno 1944: un aspetto dell’occupazione nazista non meno abominevole dei tragici fatti avvenuti sulla via Ardeatina. Eppure, all’imponenza di quelle grotte - è l’imponenza della morte, del martirio di centinaia di partigiani - si contrappone l’ambiente minimale, quasi piccolo-borghese, della caserma delle SS. Quattro appartamenti tutti uguali, dal secondo al quinto piano, con disimpegno, 4 camere, uno sgabuzzino, un bagno. Appartamenti forse destinati a famiglie romane con un magro salario statale, e si intuisce quale potesse essere la camera dei bimbi, la piccola cucina, il salottino di rappresentanza. Un senso di famiglia riunita attorno alla radio, nella speranza di ascoltare qualche notizia sulla fine della guerra.
Invece le 4 camere erano completamente spoglie, con le finestre murate dall’interno, senza luce e senza aria, in cui si pressavano fino a 20 partigiani; mentre lo sgabuzzino, nel quale a fatica ci si può stendere per terra, trasformato in cella di segregazione. Altro che senso di famiglia. Era una casa-prigione (Hausgefangnis), in cui il trattamento era crudele tanto quanto lo era nei campi di concentramento dell'alta Europa (ma nessuno sapeva cosa accadeva nell'alta Europa). Mauthausen nel cuore di Roma, all'Esquilino. E io questo non lo sapevo, non nel dettaglio.
Sapevo però che quegli ambienti hanno visto l'incarceramento e la tortura di più di 2000 partigiani romani sotto lo sguardo glaciale del colonnello Herbert Kappler. Ma perché essere reclusi in via Tasso - in un condominio - e non a Regina Coeli, nel braccio dei detenuti politici, dove le condizioni igienico-sanitarie sarebbero state di gran lunga migliori? Perché qui avvenivano i terribili interrogatori, accompagnati da sevizie e torture, volti a far rivelare ai prigionieri politici i piani della Resistenza. Kappler aveva qui il suo ufficio, in uno di questi ambienti piccolo-borghesi: la sua stanza era amabile, soffusamente illuminata da raffinate abat-jour, con molti quadri alle pareti, sempre densa di fumo di sigaro. Poteva essere lo studio di un avvocato o di un notaio. Era proprio come si vede nei film (Roma città aperta): offriva una sigaretta, e poi giù botte su botte. Troppo banale richiamare il concetto del Male, ma non mi viene in soccorso nient'altro. Le pareti delle celle, e soprattutto quelle delle celle di segregazione, erano invece graffitate.
Non è vero che la Costituzione è stata scritta e approvata nell’aula di Montecitorio. La Costituzione è stata incisa con chiodi di scarpe su queste pareti, dove si teneva il segno dei giorni che passavano, inframmezzati dalle botte prese, dalle violenze spesso inutili: perché i partigiani non parlavano, e piuttosto crepavano. Su quelle pareti prendevano forma i sogni di libertà e democrazia; mai fiaccati dalle torture e dalle umiliazioni, dal pericolo continuo e dal rischio di morire. “Lascio la vita quando più il futuro mi sorride alla vigilia del giorno più bello. Nessun rimpianto”. “Nessun rimpianto”. La Costituzione è qui.
Andrea Apollonio
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.
(giornata internazionale contro il lavoro minorile)