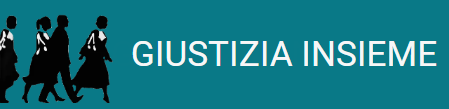Mani pulite, trent’anni e una Repubblica dopo
Il 17 febbraio 1992 Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio ed esponente di spicco del partito socialista milanese, viene arrestato dopo avere intascato 7 milioni dall’imprenditore Luca Magni per assicurargli l’appalto del servizio di pulizie.
Il segretario del PSI Bettino Craxi definisce il navigato politico “un mariuolo isolato” e nessuno lo contraddice. E invece no. La famosa frase di Antonio Di Pietro al difensore di Chiesa: “Riferisca al suo cliente che l’acqua minerale è finita” (erano appena stati sequestrati due conti denominati Levissima e Fiuggi) segnerà l’inizio della fine della Prima Repubblica, perché Chiesa decide di raccontare ai pm l’ampiezza di un sistema di corruzione che riguarda la maggioranza degli appalti pubblici e che avvantaggia politici di ogni provenienza.
Il suo interrogatorio dura una settimana. Inizia così la stagione di Mani pulite o “tangentopoli”, secondo le definizioni giornalistiche più celebri. Di lì a poco, si assiste ad una sconvolgente ondata di arresti di imprenditori e politici. I procedimenti interessano nomi di spicco, Craxi stesso, che – sarà poi dimostrato in sede giudiziale – è accusato di avere nascosto i soldi delle tangenti su conti privati, e poi il segretario del PRI La Malfa, il segretario del PLI Altissimo, il tesoriere della DC Citaristi. L’opinione pubblica è sconvolta, indignata, arrabbiata; la popolarità del pool Mani pulite alle stelle. Nella primavera 1993 l’Italia è in stallo: il Parlamento non riesce ad esprimere un nuovo governo e l’economia è in piena stagnazione.
Dopo che la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti, Craxi esce dall’Hotel Raphael e viene aggredito da un fitto lancio di monetine, mentre la gente inferocita, sventolando banconote, gli urla: “Bettino, vuoi anche queste?”; l'ex presidente di Eni, Gabriele Cagliari, si uccide nel bagno della sua cella; tre giorni dopo si suicida anche Raul Gardini; i finanzieri scoprono banconote nei divani del boss della malasanità Poggiolini; al processo Montedison, Forlani, con gli occhi sbarrati e la bocca impastata, risponde “non ricordo” al pm che lo interroga.
Di Chiesa, come di gran parte di quella stagione, si ricorda l’arresto ben più delle sentenze, che pure porteranno a condanne per cinque anni e quattro mesi di reclusione complessivi e alla restituzione di sei miliardi di lire.
Fatti traumatici, quelli del biennio 1992-1994, da cui uscirà una generazione che non vuole più il mondo che conosceva e che crede, per la prima volta dopo molto tempo, alla possibilità di un cambiamento della realtà politico-economica dell’Italia. Mentre oggi aleggiano gli impulsi di una rivalsa postuma di alcuni nei referendum sulla giustizia, della stagione di trent’anni fa, tra analisi contrastanti, rimane forse proprio quella speranza inebriante da fare rivivere nei cuori decisamente disillusi di ex ventenni ormai cresciuti.
Camilla Sommariva
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.
(giornata internazionale contro il lavoro minorile)