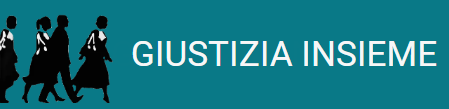Il Governo, la giustizia e quelli che inceppano la macchina
Lunedì 11 dicembre 1961, dopo quattro mesi dall’ultima delle 114 udienze tenute per l’istruttoria e poi per la requisitoria dell’accusa e la discussione della difesa, la Corte distrettuale di Gerusalemme tornò a riunirsi nell’aula della Casa del popolo dove si svolgeva il processo ad Otto Adolf Eichmann, accusato di crimini contro il popolo ebraico e contro l’umanità. E vi rimase fino a venerdì 15 dicembre: in due giorni lessero le 244 sezioni della sentenza di colpevolezza, nei giorni successivi si discusse e si stabilì la pena, la condanna a morte.
Hannah Arendt, corrispondente del The New Yorker, già nelle sue prime cronache (confluite nel famoso saggio “La banalità del male”), aveva notato che quell’aula somigliava ad un teatro con scena, proscenio, loggione ed orchestra. Era stata scelta personalmente dal primo ministro d’Israele, Ben Gurion, regista della cattura di Eichmann, rifugiatosi in Argentina, dopo la caduta del terzo Reich, per il quale aveva organizzato e meticolosamente seguito le operazioni di deportazione e di sterminio degli ebrei.
Il processo doveva essere esemplare e formalmente ineccepibile.
L’accusa era rappresentata dal Procuratore Generale, Gideon Hauser, che, a sua volta, rappresentava il Governo e ne eseguiva le attese per un giudizio spettacolare, con al centro della scena le sofferenze degli ebrei, l’antisemitismo e le conseguenze alle quali quella ideologia aveva portato; l’imputato doveva apparire come grande criminale di guerra, ideatore e manovratore di tutto ciò che avrebbe dovuto portare alla “soluzione finale”.
Con il compiacimento del Governo, Hauser accompagnò ogni prova a carico con interviste e conferenze-stampa dedicate agli orrori dell’Olocausto, mentre quando la Corte diede avvio all’interrogatorio dell’imputato, che durò più di 32 udienze, egli ripetè più volte ai giornalisti di essersi stancato di ascoltare le menzogne di Eichmann.
Ma la Harendt, nelle sue cronache, raccontò che in quell’aula, oltre al Governo, aveva visto la giustizia. La incarnava Moshe Landau, il presidente della Corte, che conduceva il dibattimento riportando tutti al tema del processo: non cos’era successo (le sofferenze degli ebrei erano già note a tutti lì nello Stato d’Israele, e anche al di fuori, visto che sedici anni prima c’era stato il processo di Norimberga), ma quali azioni fossero addebitabili a quell’imputato, non sempre capace di capire la lingua ebraica, non sempre ben tradotta dall’interprete.
Landau si adoperava per contenere la teatralità che il pubblico ministero dava ad ogni attività, ricollocava su binari più sobri le iniziative delle parti e, da ebreo tedesco, non disdegnava di usare direttamente lui la lingua madre dell’imputato per rendergli più comprensibile ciò che si diceva nel processo. Un atteggiamento di attenzione e di disponibilità all’ascolto, che, per la Arendt, erano prova di una forte indipendenza e di assoluta incuranza degli umori colpevolisti della stessa comunità di cui quel giudice faceva parte.
Chissà se, quando si confrontava con le insofferenze del pubblico ministero e del Governo per il protrarsi dell’interrogatorio dell’imputato, a Landau qualcuno raccontò di come aveva reagito un dittatore, Benito Mussolini, al moltiplicarsi delle udienze mentre si celebrava nel 1927 un processo a carico di 153 imputati dinanzi alla Corte di assise di Termini Imerese, arrestati in una vasta operazione contro le organizzazioni mafiose delle Madonie. “È mia convinzione”, scrisse il Duce al Prefetto Cesare Mori, “che occorre imprimere un ritmo più rapido, più fascista, al processo di Termini Imerese, altrimenti la liquidazione giudiziaria della mafia non sarà esaurita prima dell’anno 2000. Prenda i necessari accordi con le autorità giudiziarie locali”.
Il processo ad Eichmann portò alla pena capitale; tuttavia, la Corte spiegò che quell’uomo aveva sì commesso crimini enormi ma aiutando e favorendo altri. Parlò di reati commessi in massa, non solo per il numero delle vittime ma anche per il numero di chi li commise.
La Corte insomma rifuggì sia dalla fascinosa narrazione dell’accusa, che voleva fare dell’imputato il manovratore del genocidio, sia dall’opposta semplificazione di chi ne voleva fare un mero irresponsabile esecutore di ordini e di altrui volontà politiche.
E in questo modo i giudici, che seppero resistere alle pressioni del Governo e dell’opinione pubblica, spiegarono che la responsabilità di Eichmann era stata proprio quella di non avere deciso ma di avere assecondato il suo Governo e la sua opinione pubblica.
Cosa avrebbe potuto fare Eichmann di diverso da quello che ha fatto?
Lo spiegò bene Pier Paolo Pasolini nella sua ultima intervista rilasciata a Furio Colombo il 1° novembre 1975, un giorno prima di morire, delineando una società che stava educando tutti ad essere in competizione violenta per soggiogare e non essere tra i soggiogati, una società in cui tutti saremmo stati in pericolo. E disse cosa era necessario per rompere questa spirale:
“Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellettuali. I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no, mica i cortigiani e gli assistenti dei cardinali. Il rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o quel punto, «assurdo», non di buon senso.
Eichmann, caro mio, aveva una quantità di buon senso. Che cosa gli è mancato? Gli è mancato di dire no su, in cima, al principio, quando quel che faceva era solo ordinaria amministrazione, burocrazia. Magari avrà anche detto agli amici: a me quell’Himmler non mi piace mica tanto. Avrà mormorato, come si mormora nelle case editrici, nei giornali, nel sottogoverno e alla televisione. Oppure si sarà anche ribellato perché questo o quel treno si fermava una volta al giorno per i bisogni e il pane e acqua dei deportati quando sarebbero state più funzionali o più economiche due fermate. Ma non ha mai inceppato la macchina.”
Giovanbattista Tona
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.